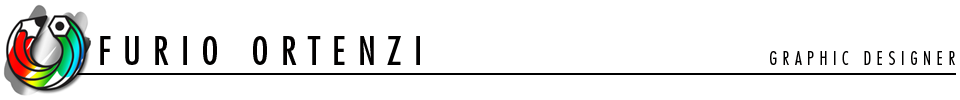Dice: « Cuki… Goèkke gheo kénghee pèa cakkioe?».
«Sarà greco…» penso immediatamente, ricordandomi di quelle volte in cui mia sorella studiava per il liceo classico e io, che ero attentissimo alle lingue antiche e misteriose, ascoltavo di soppiatto la lezione che ripeteva leggendo ad alta voce.
In effetti, quest’uomo allampanato, la faccia da greco ce l’ha. O ha quella faccia che immagino un greco possa avere. Volto scavato, sopracciglia scure e folte, occhi brillanti e scuri, faccia trascurata da almeno tre giorni con una barba non fatta che pizzica solo a guardarla, i capelli brizzolati e quindi le guance scavate, brizzolate anch’esse.
«… Pea cakkione?» ripete sorridendo e scandendo bene con fatica anche la “n”, come se si fosse reso conto di aver pronunciato male.
E io credo di sentire meglio, maledetto!
I denti sporadici e ingialliti per poco non hanno lasciato schizzare dalla bocca anche visivamente la parola “cakkione”.
«Dio! – continuo a pensare – ma proprio a Roma vieni a dire “cakkione” a me, che potresti rischiare un linciaggio se solo io fossi un po’ più incazzoso? … A me?».
La signora, in piedi, – quella coi capelli tinti e foltissimi, da sembrare una parrucca blu scuro tanto erano neri – aveva uno sguardo disgustato e la bocca rosso vermiglio, stirata ai lati quasi a circondare il mento, faceva in modo che tutto il suo disappunto non fosse frainteso. A ogni sobbalzo dell’autobus le ballava il grasso delle braccia, a fatica ancorate al corrimano del sedile, e le faceva scoppiare il vestitino bianco a fiori blu, porpora, gialli e marroni, che a malapena la conteneva. Ma cercava in ogni modo di non andare anche solo a sfiorare il greco che, nella sua giacca grigia stropicciata e camicia a quadri, non proprio pulita e forse grigia anch’essa, non se ne curava.
«Cuki kinnòe?…» insiste lui.
«Abbèllo de casa!» penso, rivolgendogli uno sguardo che vuole sostenere una sfida «Il greco non lo parlo! E se sei venuto fino a qua, pe’ pijamme pe’ ‘l culo, co’ tutti i problemi che ciavete, va’ da ‘nantra parte!», ma la sfida che esce dalla mia bocca, è «I’m sorry?».
Un ragazzo e una ragazza, seduti l’uno sull’altra proprio su quel sedile dove la signora si tiene innervosita, immediatamente si guardano e mi prendono in giro ripetendo “…aimzorry? …Aimzorry?…” quasi senza emettere suoni, ma con la bocca uguale a quella della signora in parrucca.
Con una evidente maschera altezzosamente, ma beffardamente schifata.
«Amò… mào stai a sentì a quòo scemo?» fa la ragazza a quel grumo di ignoranza impertinente spalmato su di lei. Si guardano e ridono fingendo di nascondere il fragore del loro divertimento, scambiando l’uno con l’altra mossette per aumentare la comicità della situazione e quasi si strappano di dosso le cuffiette dell’iPad dal quale fino ad allora stavano condividendo musica, con un auricolare ciascuno.
«Ma chi, quer mongoloide?», scoppia in una risata lui «Gu gu gu gu!» continua sbeffeggiando, mentre crede ovviamente di imitare il greco. E di essere spiritosissimo, cosa che la ragazza pare confermare con la sua risatina divertita ed ebete.
Dal canto suo, il greco dava quasi segno di capire, alzando gli occhi al cielo e mostrando però una velata comprensione verso quei due scellerati, che avrei preso a schiaffi per più di un motivo. «So’ ragazzi… Quando non sanno parlare una lingua, fanno così…», pareva pensare.
E allora torna a puntarmi con lo sguardo, come se io, di fronte a quella scenetta disgustosa e infantile, avessi il dovere di capire.
Mi guarda intensamente, come per preludere a un ulteriore sforzo di comunicazione.
Infatti, aprendo il palmo della mano verso di me in segno di attesa, ripete sillabando: «Cuki, kignòe». Un attimo di pausa. «Goè ke gheo kenghée…» dice lentamente, accompagnandolo con un gesto della mano a paletta, come se indicasse l’uscita dell’autobus.
In quel momento, l’autobus fa una curva che ci fa quasi perdere l’equilibrio. Gli alberi del viale che percorrevamo scoprono finalmente la stazione di Trastevere. E l’occhio mi cade su una grossa valigia che non avevo notato prima, ma che il greco teneva stretta tra le gambe, quasi a costo di cadere.
Valigia. Stazione.
Oddio! La fermata per la stazione!
«Goè ke gheo kengée pea cacchione?» ripete ancora una volta.
La stazione! Altro che “cacchione”.
«Dov’è che devo scendere…?» traduce immediatamente il mio traduttore simultaneo mentale.
Questo poveraccio aveva un problema evidente al palato!
«Qui! Qui! E’ la prossima!» rispondo io, raccogliendo la soddisfazione delle facce incredule della signora grassa e di quei ragazzetti maleducati.
Lo aiuto a far scendere la valigia.
Lui apre quel volto scavato in un sorriso luminoso, riconoscente.
E la parola «Gàcchie!» mi sembra la più bella parola del mondo.