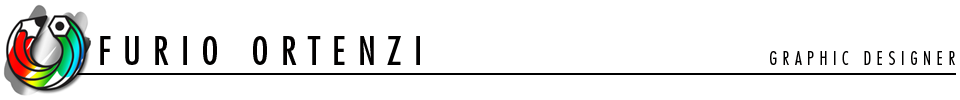Ho conosciuto Rosa tanto tempo fa.
Ha da sempre abitato l’appartamento di fronte al nostro, sul nostro stesso pianerottolo. Anzi, per dirla meglio, ha iniziato a vivere il suo vicinato con noi e la sua silenziosa esistenza nella casa con giardino adiacente la nostra, molti anni fa comprando quell’appartamento dai nostri primi vicini.
Non ricordo quand’è stata la prima volta che ci siamo incontrati, Rosa ed io, ma ho imparato a conoscere la sua bellezza interiore, appena guastata (chissà se si può dire anche “vivacizzata”?) da un’attitudine al pettegolezzo, dall’insistenza a chiedere farfugliando, dicendo cose “a metà”, un’insistenza tipica di chi ha il timore di dire le cose – parlava sempre sottovoce e a mezza bocca , ma dimostrava di sapere tutto di tutti – perché forse il suo problema era quello di farle, le cose.
Delegava per natura. Infatti indossava sempre uno sguardo furbetto irresistibile.
Quando c’era un problema, non esitava a “suggerirmi” di contattare l’amministratore non appena ci incontravamo e, a volte, suonava alla nostra porta per iniziare una specie di chiacchiericcio confuso il cui tentativo era quello di coinvolgermi in questo o quel problema condominiale.
Faceva parte del nostro lessico famigliare: esclusivamente quando qualcuno della nostra famiglia tentennava a rispondere a una domanda. Per esempio, mia madre mi chiedeva “Hai fame?”, io rispondevo il mio solito distratto e assente “…boh?”, lei prontamente chiedeva ancora “A chi lo devo chiedere? A Rosa?” e naturalmente io rispondevo con un sorriso chiedendo subito “Che mangiamo?”. Stile umoristico, condito di reminiscenze popolari, tipico della nostra famiglia.
Non mi ricordo quando ho capito che Rosa dipingesse. Ricordo vagamente di essere entrato in casa sua, una casa buia e disordinata, e di avere scorto, tra le cose ammassate a caso, un cavalletto con sopra una tela appena cominciata.
Mi apparve subito sotto un’altra luce e quel disordine assunse immediatamente il sapore di un ordine prestabilito, incomprensibile per la gente comune.
Un giorno, mentre tornavo a piedi da una visita all’ospedale dove mia madre era ricoverata, mi sento chiamare di lontano. Era Rosa.
Naturalmente tornammo a casa insieme e, durante la passeggiata – la più lunga in comune da quando ci conoscevamo – decidemmo di darci del “tu”.
E mi resi conto con piacere che parlava interrompendosi subito ad ogni mio cenno fisico: un dito fra le labbra che significasse che avevo capito e che forse avevo qualcosa da dire, un mio sospiro che sottolineasse che sul suo ragionamento avrei voluto argomentare, e anche solo un colpo di tosse bastava per attirare la sua attenzione.
E poi non interrompeva mai. Non parlava “sopra”, come è andato di moda dalla nascita dei talkshow in poi anche tra la gente comune. Seguiva attentamente una conversazione e a una mia pausa ragionevolmente lunga argomentava le sue ragioni o raccontava le sue storie.
In quella conversazione mi resi conto che un dialogo potrebbe essere scritto su un pentagramma dove un pianoforte accompagna con riflessioni e pensieri intonati il “solo” di una chitarra e viceversa, quando la chitarra termina il suo intervento e inizia ad accompagnare con un “pizzicato” o un arpeggio la parte solista del piano. E tutto è armonico e piacevole da ascoltare, persino da lontano, persino soprappensiero.
Non ho mai saputo il suo nome.
Lo chiamavo semplicemente per il cognome: Rosa.
Un omone alto e segnato dalla vecchiaia che si intravedeva quasi unicamente nel suo modo barcollante di camminare.
Barcollando, qualche settimana fa è finito sotto un’automobile mentre attraversava la strada.
I figli hanno già venduto la sua casa.